Proviamo a figurarci per un attimo qual è il retroscena mentale con cui ragiona ed opera la Logica del Global Impero. Supponiamo che i grossi gruppi industriali mettano in atto una strategia per colonizzare il nostro immaginario emotivo e patrimonio gustativo attraverso azioni efficacissime nonché immediate.

Dopo le loro belle ricerche di mercato, questo dicono i nostri Architetti del Gusto: “La grande massa amorfa la freghiamo già per benino con prodotti alimentari di largo consumo e con milioni d’ettolitri di vini da GDO (Grande Distribuzione Organizzata): prodotti d’uso quotidiano dai marchi riconoscibili, acquistati da tutta la maggioranza silenziosa.
L’altra nicchia dei consumatori con la puzza al naso, quelli più recalcitranti che si pretendono di gusti più difficili, quelli ce li conquistiamo pian piano; monopolizziamo anche loro, figurati, proponendogli cibi e vini apparentemente più ricercati almeno all’apparenza in etichetta, anche se non necessariamente nei fatti. L’omologazione, anche se del non facilmente omologabile, è il nostro mestiere!”
Secondo voi in Casa Balilla il giorno che la nicchia dei biodinamici, bioetici e bio-qualcosa s’allargherà sempre più, non troveranno una strategia di marketing vincente volta ad accaparrarsi anche questi consumatori più “avveduti”, attenti e meno facilmente omologabili?
Presto in arrivo troveremo sugli scaffali le fette Biscottate “Rudolf Steiner” della Mulo Bianco allo stesso modo come già hanno cominciato con i biscotti da “cottura a vapore” o le merendine al “lievito madre” fatte a mano una ad una da nonnetta Balilla (ma allora non sarebbe piu opportuno chiamarlo “lievito nonna”?)
Il rischio dell’ingannevole e oramai trita retorica del contadino “buono pulito giusto” è sempre appostato dietro l’angolo della mistificazione, pronto ad adulterare anche le migliori intenzioni, ad inquinare i propositi positivi di chi ci crede per davvero e si sforza onestamente di attuare i suoi romantici ideali.
Lasciando ora per un attimo da parte i mediatori di vino consumati da trattative scafate e compravendite da mercanti navigati, ho paura invece che per un timido consumatore medio di vino, tutta questa frammentazione confusionaria dei produttori (produttori di vino soprattutto) in frange avverse d’artigianali, naturali, sostenibili, resistenziali, celopuristi… tutto il comparto cioè dei vignaioli eco-sostenibili parcellizzato in associazioni, sindacati, gruppi, federazioni, partiti… possa alla fin fine immettere sul mercato ancora più caos di quel che già non ci sia, innescando quello che potremmo tranquillamente definire: Effetto Brian di Nazareth.
Ricordate il Fronte Popolare Giudeo o Fronte Popolare di Giudea dei meravigliosi Monty Python? Insomma mi sovviene quel che scriveva Fabio Rizzari nel suo il bottigliere qualche settimana fa, quando reduce da una manifestazione sui vini naturali riportava la frase fulminante di una produttrice la quale illumina come un lampo nella notte tutto un magma lavico di rivalità intestine e competizioni testosteroniche affermando che nel sottobosco produttivo/commerciale del nature: “Fanno a gara a chi ce l’ha più puro”.
Per essere più esplicito, sono pienamente allineato al pensiero di un caro amico prosecchista in Veneto, il sensibile, coscienzioso Silvano Follador che tempo fa con ragionevole e sentito pathos mi scriveva quanto segue:
“Da viticoltore dico sì al rispetto della terra ma senza mettere in croce chi pur con la buona volontà, l’onestà intellettuale e la coscienza pulita, adotti a seconda della gravità dei rischi, rimedi più convenzionali, ma non per questo impattanti al suolo e alla salute della gente, in merito alla gestione delle avversità in campagna o d’altre urgenze innescate dall’andamento climatico. Coltivare la vite in Sardegna non è come coltivarla in Veneto. Vinificare un rosso non è come vinificare un bianco. Produrre uno spumante non è come produrre un vino fermo. Non tutte le annate sono uguali, c’è quella dove non finisce mai di piovere e la peronospora ti divora l’uva e quella che riesci a salvare è poi attaccata da muffa o marciume. C’è poi l’annata in cui per due mesi non piove e c’è un caldo che ti brucia le piante. Dico per questo no ai disciplinari intolleranti, no alle certificazioni rigide e assolutamente no ai gruppi. Basta divisionismi e separatismi. Basta stupidi e assurdi paletti e restrizioni. Che ogni produttore lavori come meglio creda ma con etica e rispetto verso la terra, verso il consumatore e verso se stesso”
L’ideale per ogni consumatore avveduto sarebbe allora un mondo alimentare in bianco e nero — senza neppure un’opzione di grigio — dove di ogni cibo o bevanda si possa semplicemente affermare buono o non buono. Ma fuori dalle nostre case regna un cosmo alimentare straripante all’eccesso di coloranti industriali, aromatizzanti e additivi d’ogni specie, per cui lo schema semplificato del mi piace/non mi piace avviene all’interno di un network economico, culturale, sociale, etico, estetico, molto complesso, di condizionamenti, raggiri, pressioni senza fine.
Facebook con il suo sistema di specchietti per le allodole in formato di like o reazioni con le faccine varie d’emoticon/smiley, ne è un esempio lampante. Siamo tutti chi più chi meno ad ogni livello suggestionati dal posizionamento del brand contestualizzato in ogni habitat sociale, sistema di classe, strato di conoscenza, livello di raffinatezza o brutalità del gusto.
Come possiamo altrimenti prescindere dai condizionamenti dell’etichetta, dell’influenza e riconoscibilità del marchio e pensare che ci piaccia o ci spiaccia qualcosa “in perfetta libertà e autonomia” quando la verità è che qualcuno più sveglio di noi — è la sua mission restar sveglio al posto nostro quando noi dormiamo — è lo stesso qualcuno che deciderà a tavolino cosa debba piacerci e perché, a prescindere dal nostro gusto personale? Come fanno?
Creando un gusto individuale massificato, cioè già dominato, addomesticato e spersonalizzato all’origine da un’industria alimentare che ci nutre fin dall’infanzia con latte in polvere, zuccherini da foche e pseudo-cibi liofilizzati.

Mettiamo il caso che fin da bimbo il consumatore X è abituato a tracannare acqua con aggiunta di zucchero; difficilmente in età adulta apprezzerà un barolo tannico/acido/rasposo (un gusto che “nell’ambiente” si tende a definire tradizionale) e ad ogni buon conto per far sì che ciò invece avvenga è necessario che il tizio X sia educato o educhi il proprio palato al sapore tannico/acido/rasposo.
Se invece ipotizzassimo che tale sapore fosse improvvisamente di moda, come è già avvenuto per il gusto noccioloso, dolciastro di barrique o il sapore avvanigliato di tostatura del legno (il gusto internazionale, moderno), all’aumento della domanda di tali baroli tannici/acidi/rasposi, aumenterebbe anche l’offerta medesima (cioè la produzione).
Più la produzione sottomessa al mercato s’accresce però, più potremmo perdere in spontaneità e in naturalezza qualitativa del vino — sempre ammesso che l’attitudine produttiva e l’uva di partenza siano di qualità — a favore di una fabbricazione scientemente elaborata a tavolino, sempre più lontana da un sano approccio artigianale che dovrebbe invece preservare la manualità, la bontà, la salubrità.
Accrescendo l’indotto aumentano anche i trattamenti da fare, per cui il lavoro da artigianale diventa industriale, meno a misura umana cioè, e quindi è possibile anzi certo che il vino debba essere “trattato” con massicce, varie ed eventuali dosi farmaceutiche a base di polverine enotecniche, inoculi infinitesimali di lieviti selezionati, filtrazioni sterilizzanti o con l’aggiunta d’altri intrugli enzimatici da stregoni di cantina, al fine di costruire così il gusto di moda del momento, che si vende bene e tanto a container, cioè il barolo dal gusto: tannico/acido/rasposo, che abbiamo portato a titolo d’esempio paradossale.
Mi viene adesso adesso in mente un titolo illuminante del filosofo Günther Anders che approfondiva il tema dell’anima e della distruzione della vita nell’epoca della terza rivoluzione industriale: L’Uomo è Antiquato. Siamo al punto nodale allora: la falsificazione/manipolazione del gusto che la Tecnica sovrappone alla Vita e la Chimica alimentare ci propina fin da quando siamo nella placenta, strozzandocelo con l’imbuto ficcato in gola come fossimo oche per la produzione del fegato grasso a batteria.
Forse non ce ne accorgiamo perché è una pratica lenta, inesorabile ma costante che subiamo passivamente fin dalla placenta. Eppure tutto il patrimonio cromosomico del nostro presunto gusto personale è un insediamento culturale che l’industria alimentare c’inocula nel cervello e c’inietta nell’apparato digerente a milioni di madri, padri e figli, proponendoci il sapore di qualcosa al sapore o sentore di qualcos’altro; “bevanda al gusto di caffè” tanto per dirne una o vedi come poco sopra si diceva in merito dell’abuso dei legni, delle pozioni chimiche, delle tecniche troppo invasive e le polverine magiche in enologia che una volta lanciati quei vini che contano più sul mercato, dettano legge in tema di gusto autorevole pregiato, imponendo dei valori organolettici condivisi da tutti ma ahimè falsificati. Si, dei valori contraffatti che stabiliscono proprio così le regole del gioco dell’intero indotto merceologico “di come e di cosa deve o non deve sapere un vino.”
Questo della sofisticazione dei sapori alimentari è un vero e proprio sopruso primordiale, al fine di confondere i parametri sia oggettivi che soggettivi di ognuno di noi. Un controllo generalizzato della coscienza che abbiamo o dovremmo avere del gusto d’ogni prodotto edibile/potabile, che mischia le carte in tavola — la tavola attorno a cui ci nutriamo — su quello che è o dovrebbe essere il sapore originario o comunque peculiare di un pomodoro, una patata, una spiga di grano, un peperone, il sapore connaturato di una determinata cultivar d’oliva o grappolo d’uva ad esempio, a seconda della varietà, del clone, della selezione dal vivaista o selezione massale della pianta, della tecnica di allevamento, tipologia del porta-innesto, composizione del suolo, andamento microclimatico, trattamento agronomico etc.

Fondamentale infine resta la conoscenza diretta del nostro oggetto d’interesse, anche se su larga scala la cosa diventa quasi impossibile. Bisogna però non mollare e tentare di andare sempre alla fonte di quel che ci nutre e ci abbevera. Dobbiamo purtroppo però fare i conti con la definizione di consumatore “medio” che in verità il più delle volte sottende un consumatore “mediocre”, un consumatore distratto, ovvero indaffarato da una vita d’impegni quotidiani, quando non addirittura passivo o quasi del tutto addormentato.
Trovo che questo tema della “fiducia” produttore/consumatore sia essenziale ed è il campo di guerra sanguinaria su cui si inscenano le battaglie già attuali e si svolgeranno le lotte senza quartiere del futuro prossimo, relative al controllo delle materie prime alimentari o alla gestione delle risorse naturali, l’uso pubblico/privato delle sorgenti d’acqua, delle sementi, delle radici, dei frutti della terra.
Ci sarebbe da scriverne un saggio d’antropologia-filosofica sulla fiducia robotica, sulla superficiale ingenuità con cui ci affidiamo al pilota dell’aereo di turno su cui voliamo, alle dichiarazioni cialtronesche di un politicazzo in TV, alle retroetichette — quanto affidabili? — di un pacco di biscotti o a uno slogan assai mistificatorio che pubblicizza un vino libero, vegano, naturale, non-solfitico.
Infine, il messaggio nella bottiglia di questo mio ragionamento — una bottiglia dove si spera sia stato custodito del buon vino in precedenza — è che bisogna interfacciarsi direttamente con la persona che manifattura il prodotto che assumiamo (farina, legumi, uova, latte, vino, carne, pesce, miele, formaggi e quant’altro). Incrociare il suo sguardo, stringere le sue mani, visitare sul campo la sua sfera d’attività, immergersi quanto più naturalmente possibile nel suo habitat.

Ma chi ha oggi più tempo, energia, volontà, denaro per fare questo investimento su se stesso e sul proprio benessere psicofisico, in questo pazzo pazzo mondo dove si lavora fino all’esaurimento nervoso per pagarsi a malapena il privilegio di lavorare? Che mondo è mai questo, pianeta in fuga da se stesso sempre più mordi-e-fuggi a misura disumana dei fast-drink/fast-food imperanti dall’Amazzonia a Tokyo, dalla Terra del Fuoco alla Lapponia?
Nell’atomismo pre-scientifico alla base del pensiero poetico-filosofico di Lucrezio c’è un termine sostanziale derivato a sua volta dal materialismo di Epicuro e Democrito: clinamen. Il clinamen rappresenta la deviazione “innaturale” e casuale dallo schema della materia che ricompone a sua volta il disegno del “naturale”.
Dallo scontro e dall’urto degli elementi dovuto a questa deviazione si crea il movimento degli atomi per cui la natura dà vita alle cose. Ecco, forse bisognerebbe, chissà, ricercare le risposte efficaci agl’angoscianti interrogativi di poco fa proprio in questa deviazione dallo schema a ragnatela dell’industria alimentare, per ricomporre nuovamente la via di fuga alternativa della produzione artigianale caratterizzata da una sostenibilità di fatto e non di facciata.
Il vino si rigenera in purezza attraversando l’impurità delle fecce. Dagli scontri sterili, dagli urti violenti, dai contrasti anche i più stridenti e brutali, si scatena sempre un moto vitale tutto nuovo. È una corrente d’energia fertile, genuina tanto che dal bozzolo greve e buio del consumatore addormentato in potenza del presente non è affatto inverosimile possa avvenire la metamorfosi in una farfalla di leggerezza e di luce del consumatore consapevole finalmente risvegliato in atto, cioè il consumatore avveduto del futuro prossimo che vuol soprattutto dire: il cittadino molto più civile, il contribuente assennato, il genitore accorto.

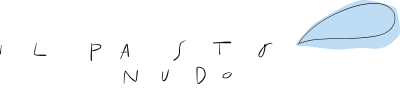

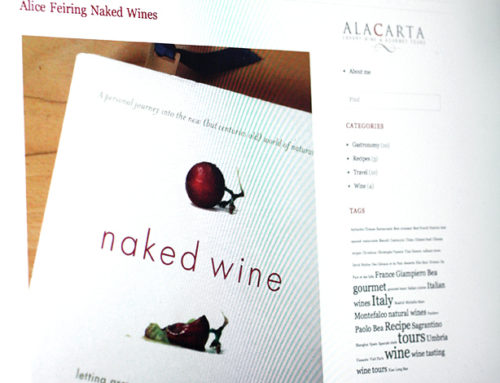
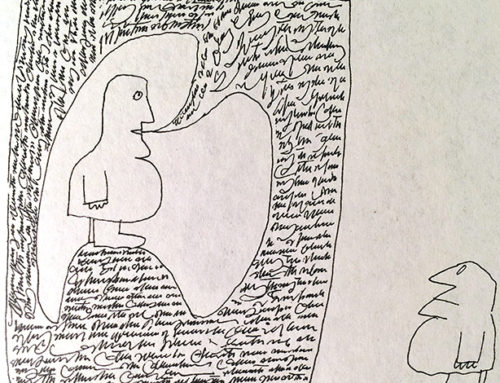

Scrivi un commento