Oggi volevo pubblicarvi una ricetta e invece vi beccate uno dei miei editoriali sul mondo visto attraverso la finestra della cucina. Ho da dire quel tipo di cose che quando le senti non te le puoi tenere dentro e se non le appunti subito da qualche parte tornano per sempre nell’oblio delle lacrime della notte dell’automa di Blade Runner.

Una cosa tipo scrittura automatica, non so se avete presente. A volte ho la sensazione di essere una specie di traduttore di sensazioni globali, tanto è vero che mi capita spesso di pensare qualcosa che non scaturisce da ragionamenti precedenti e vederla poi realizzata o raccontata da varie altre persone in giro sulla rete.
Forse sono un divulgatore scientifico di energie circolanti nel mondo. O magari semplicemente registro senza accorgermene ciò che accade attorno a me e all’improvviso i miei neuroni uniscono i puntini e vaticinano.
La lentezza, appunto, la calma. Ho un rapporto contrastante con questi stati d’animo, con questi modi di fare ma soprattutto di essere. Ci sono nata, lenta, in una città che ha fatto di questa caratteristica un modo di vivere e di reagire alle cose; a volte in modo affascinante, altre disastrosamente. Perché il confine tra ponderatezza e lassismo è sottilissimo, e poi molto più spesso di quanto si dovrebbe, l’una viene scambiata con l’altro, in particolar modo dai generalizzatori seriali, razza pericolosissima.
Fino a una certa età mi sembrava di avere il mondo in mano, se avevo la calma di fare quello che dovevo fare. Ogni cosa era possibile, ogni situazione risolvibile, se solo c’era il tempo per smontarla, osservarla, capirla e rimontarla, fino a quando non avevo imparato. Poi all’improvviso qualcuno mi svegliò a suon di schiaffi. Prima roba successa in quella che pensavo essere la mia famiglia, ma si rivelò un groviglio di autolesionismi incomprensibili, e poi – soprattutto – l’improvvisa consapevolezza che se volevo qualcosa me la dovevo procurare da sola, e di conseguenza l’ingresso nel mondo del lavoro estivo, con il quale riuscivo a pagarmi in parte il costosissimo IED.
È stato così che ho conosciuto l’Alto Adige, da dietro i banconi dei bar dove servivo ettolitri di birre ai ragazzi del posto e innumerevoli got de vin blanc ai vecchietti che tornavano dalla chiesa; da dentro la divisa di cameriera ai tavoli con tanto di grembiulino bianco e Birkenstock con calzini, e dalle camere moquettate degli alberghi un po’ tutti uguali (ma quanto sono più belli i Garnì, con i mobili dei nonni della proprietaria e l’uovo fresco della gallina dietro casa a colazione?).
È stato sempre lì che per la prima volta ho dovuto chiudere in un cassetto la mia napoletanità e adottare i ritmi lavorativi convulsi della gente del posto, gente di montagna fredda e frizzante, gente svelta, veloce, efficiente e con poco tempo per riflettere. E come ogni emigrato che si rispetti, sono diventata la prima denigratrice della lentezza della gente del sud, dell’inefficienza che ne derivava. Essì che ho avuto un padre che mi insegnava a fare sempre *almeno* due cose insieme. Quasi un’avvisaglia.
Da lì ho passato tutta la vita a migliorare il mio aspetto lento e ci sono riuscita talmente bene che sono rovinosamente rotolata dall’altro lato dello specchio: “non ho abbastanza tempo per fare tutto ciò che devo fare!!!”, con grande disappunto della mia tiroide. Adesso, nel novembre del 2016, tra una crisi economica e sociale, una scossa di terremoto e un tornado tropicale (l’altro giorno qui c’era scirocco, oggi 9 gradi e tramontana…), mi sto rendendo conto che forse ho un filo esagerato.
E cosa me l’ha fatto capire? Il cibo, ovviamente, o meglio la sua preparazione. È incredibile come tutto sia collegato e quanto sia atavico e ricco di significati il gesto di acquisire un alimento e lavorarlo, trasformandolo in qualcosa che migliora la nostra giornata e quella dei nostri cari, delizia i nostri sensi e trasmette a chi se ne serve l’energia che abbiamo avuto nel farlo (ecco perché non bisognerebbe mai cucinare arrabbiati).
Ecco. Il miglior modo quindi di reagire alla confusione che abbiamo intorno, oltre alla resilienza e alla consapevolezza, io credo sia *rallentare*. E quale miglior luogo per iniziare se non la cucina di casa nostra? Lo dice anche il mio amato Pollan in Cooked:
“Esiste una persona al mondo a cui piaccia davvero tagliare le cipolle? Be’, magari c’è qualche buddhista che si abbandona completamente all’operazione, finanche alle lacrime, in ossequio al principio che «quando tagli le cipolle, taglia le cipolle e basta». In altre parole, non opporre resistenza, non lamentarti, ma mentre lo fai sii presente: lì, in quel momento.
[…] paradossalmente, persino una cosa noiosa come tagliare le cipolle, appena cessa di essere obbligatoria, diventa più interessante e problematica
[…] Non appena abbiamo delle scelte sul modo in cui passare il nostro tempo, ecco che all’improvviso esso diventa molto meno abbondante, ed *essere* in cucina – tanto in senso letterale, quanto in senso buddhista – diventa molto più difficile. All’improvviso, le scorciatoie sembrano più attraenti, perché nel frattempo si potrebbe fare qualcos’altro: qualcosa di più urgente o semplicemente più piacevole.
[…] Dubitavo seriamente che avrei mai raggiunto lo stadio dell’illuminazione nel momento in cui, quando tagliavo cipolle, stavo *solo* tagliando cipolle […] Forse, però, potrei almeno arrivare al punto di sentirmi completamente a mio agio tra i fornelli, e di mettere bene a fuoco – qualsiasi cosa sia – l’alternativa alla «fine della cucina».
Insomma, se vogliamo ricominciare a stare bene – come quando eravamo bambini e avevamo tutto il tempo del mondo – forse dovremmo riappropriarci del tempo giusto per fare le cose. E come fare, con il lavoro, la casa, gli impegni, la città gli amici le uscite i social le serie su Sky e Netflix le code la burocrazia e tutto il resto appresso?
È necessario un cambio di paradigma, e prima cominciamo a pensarci, meglio è.

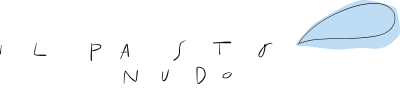




Domenica é stata una brutta domenica, e nel momento piu’ difficile sono andata in cucina ad impastare la pizza, per poter acquietare per un momento le emozioni in subbuglio, sapendo che avraei dovuto dedicare il giusto tempo a quell’operazione. Forse avrei dovuto aspettare di calmarmi, pero’ anche solo il pensiero di preparare l’impasto che forse la sera mi avrebbe dato piacere condividere in famiglia mi ha sostenuto positivamente.
bello! d’accordo direi su tutto… mi dispiace di essermene accorta tardi e di aver rallentato da poco: se ne avessi avuto consapevolezza prima, forse avrei fatto scelte diverse e magari, dato che mi trovo a reinventarmi a 40 anni, magari mi troverei in una condizione migliore!
ma non è mai troppo tardi… :)
@FrancescaV: Ma hai fatto benissimo! Quello che intendevo io era cucinare mentre si è tesi e smettere di cucinare ancora con tutta l’energia negativa, che secondo me inevitabilmente passa al cibo. A quanto ho capito invece tu hai usato l’atto del cucinare per rilassarti, cosa secondo me importantissima <3
@Alessandra: Beh io ne ho 48 e adesso sto iniziando a capire!! Sei assolutamente in tempo, tra l’altro i quarant’anni sono un momento magico nella vita di una donna :-)
Cara la mia izn .. tu che di cose buone ne sai e ne fai…voglio raccontarti questo.. io ho “dovuto” ,purtroppo o PER FORTUNA rallentare di molto negli ultimi mesi… l’estate questa passata è stata creo per me la più difficile dei miei anni… sto cercando di uscire da un problema che mi porto dietro ed appresso come la palla al piede dei carcerati da troppo tempo…. è un qualcosa di subdolo, silenzioso e silente… si chiama ANORESSIA … (ma tu, Manu, non eri quella laureata n scienza della nutrizione???? si, sono io.. ma che vuoi che ti dica cara la mia izn) .. .bene… quando quindi arrivi ad una condizione che ti permette a fatica di fare le cose… rallenti..rallenti..rallenti… ed io.. che “DEVO FARE QUESTO, QUESTO e QUESTO” … mi sono ritrovata a chiudere gli occhi e dormire il pomeriggio perché sentivo il BISOGNO DI FARLO.., mi sono ritrovata a … fare piano… scegliere UNA COSA SOLA DA FARE (perché tanto non sarei riuscita a farne altre) …
ma il bello è che la mia lentezza ed il mio rallentamento era già dentro di me… stava solo aspettando il giusto momento (ceerto magari poteva paventarsi in maniera diversa..o comunque) e quindi già da un po’ cerco di rallentare il più possibile di sforzarmi.. più a livello mentale (perché è più una questione di testa che deve abituarsi) di fare piano.. di andare VOLUTAMENTE PIANO… ed è bellissimo…
ed anche se c’è polvere sulla credenza di casa .. se i vetri della camera son puntinati di pioggia.. beh.. dico ok… oggi la camera, domani la credenza.. e se non è domani perché un amico mi chiama e vado a far due passi.. pazienza…
non sono ancora uscita dal problema… e devo allenarmi molto per tornare ad AMARMI come si deve… perché “lei” è sempre li…. dietro l’angolo…
Manu.
Ci pensavo proprio oggi, mentre pelavo un chilo di piccole patate, al vivere quel momento con la lentezza dovuta, e imposta dalla piccola taglia dei tuberi: ho avuto un breve moto di stizza perché così piccole richiedono una certa attenzione con il pelapatate altrimenti ti porti via anche qualche pezzo di dito, e quindi richiedono lentezza e una presunta “perdita di tempo”… poi mi sono detta che forse avrei fatto meglio a pensare al “qui e ora”, a pelare le patate pensando solo a quello senza andare con la testa alle altre cose che mi aspettavano da fare, e che in fondo una dopo l’altra le avrei pelate tutte, infine. Il risultato è stato grandioso: il tempo passato mi è sembrato infinitamente più breve. È bastato, come hai detto tu, un semplice cambio di paradigma.
Cara Izn tu lo hai capito a 48 anni….. io ne ho 63 e l’ho capito da tre….. da quando sono approdata alla pratica di yoga: ed è stato stupefacente! entrare nell’ordine d’idea del qui ed ora, difficile per noi occidentali, ma appena aggiusti la mente è un toccasana nella frenesia della vita che ci coinvolge. Nello yoga Hata ci hanno suggerito di fare, durante le attività di ogni giorno, una “campana di consapevolezza” fermarsi – cioè – e ascoltare il silenzio dentro di noi con lunghi respiri. funziona. ti ricollega al respiro cosmico a cui apparteniamo e ti fa guardare le cose in modo diverso……